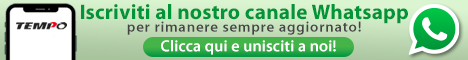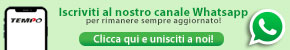Ottavo anno consecutivo di calo per la popolazione scolastica della scuola elementare carpigiana, scesa per la prima volta lo scorso settembre sotto quota tremila: 2.978 unità. A pesare è il calo delle nascite sulla base delle quali si sarebbero dovuti prefigurare evidenti effetti già dall’anno scolastico in corso perché sulla base di quei numeri sarebbe potuta venir meno una scuola primaria e invece ci sono 254 bambini in più rispetto ai nati e residenti a Carpi, di età compresa tra i sei e i dieci anni, che si sono trasferiti nella nostra città senza esserci nati e frequentano le scuole elementari carpigiane. Un vero e proprio ‘salvagente’ che non evita la necessità di guardare al futuro preoccupandosi non solo degli immobili di proprietà comunale ma anche di come cambierà la vita in classe. “Guardando le dinamiche demografiche e le previsioni si avverte un senso di ineluttabilità – afferma l’Assessore all’Istruzione del Comune di Carpi Giuliano Albarani – ma è anche vero che ci sono spesso variabili in grado di invertire la direzione di marcia. Non dobbiamo sottovalutare il problema dell’inverno demografico ma l’atteggiamento non è da fatalisti: da una parte nuovi cittadini carpigiani indipendentemente dalla provenienza potrebbero scegliere Carpi per il loro progetto familiare controbilanciando il calo delle nascite, che ultimamente comunque fanno segnare segnali di ripresa nella prima infanzia”.
Assessore Albarani, Carpi attrae dunque per i servizi educativi. Vi siete fatti un’idea di chi la sceglie e da dove provengono i duecentocinquanta bambini che, pur non essendoci nati, frequentano le scuole primarie carpigiane?
“Oltre ad alcuni alunni provenienti da comuni limitrofi, ci sono nuclei familiari che arrivano da un altro comune modenese, da un’altra provincia dell’Emilia Romagna o da un’altra regione, e scelgono Carpi. A questi si aggiungono coloro che arrivano da un’altra nazione. Secondo i dati del Centro Unico di Iscrizione a Carpi sono accolti ogni anno nella scuola primaria una quarantina di nuovi bambini, arrivati d’estate oppure in corso d’anno. E’, quindi, ragionevole pensare che in 5 anni questo fattore contribuisca parzialmente all’aumento rilevato, anche se permane anche una forte mobilità di alunni con cittadinanza non italiana in uscita da Carpi. Infine c’è il fenomeno dei bambini ‘anticipatari’: in Unione Terre d’Argine oscillano tra l’1 e 3% all’anno, a seconda degli anni”.
Pur riducendosi progressivamente il numero di bambini per classe, arriverà un giorno, non troppo lontano, in cui un edificio scolastico resterà vuoto. Ci state pensando?
“Non sono stati fatti ragionamenti su una prospettiva di medio e lungo periodo rispetto alla disponibilità di un plesso di scuola primaria per altri usi. L’obiettivo principale è stato ed è ancora quello di tenere aperte tutte le nostre scuole, che hanno aspetti di grande qualità e diversità nell’offerta, e comunque non ridurre gli spazi – spesso non così ampi come ci segnalano docenti e genitori – comunque a beneficio del sistema di educazione e di istruzione territoriale”.
Diminuiscono gli alunni ma aumentano le complessità?
“Le cosiddette classi pollaio non esistono più e non potrebbero più esistere, non solo perché non ci sono più condizioni di sovraffollamento. In quella metafora c’era il riferimento a una profonda omogeneità, quella dei componenti del pollaio stesso. Oggi gli studenti sono fortemente diversificati per storia familiare, per competenze di carattere linguistico o per disabilità. Anche nel passato c’erano differenze ma molto spesso venivano ignorate o, in qualche modo, levigate. Adesso, fortunatamente, la scuola è molto attenta all’individualizzazione dei percorsi e, prima di immaginare uno svuotamento dei plessi e delle strutture, bisogna immaginare che la riduzione del numero di alunni per classe sia la condizione ottimale per fare sempre di più della didattica personalizzata. C’è preoccupazione per il momento, ma può essere un periodo di transizione da una didattica di tipo ‘fordista’, in riferimento a una platea indifferenziata di soggetti a cui non vengono riconosciute peculiarità, a una didattica personalizzata, capace di lavorare sul dettaglio”.
Quali sono le sfide nel prossimo futuro e come le state affrontando?
“All’interno del Patto per la scuola, partendo dalla sperimentazione di rete in corso in tutte le scuole primarie e, in prospettiva futura, secondarie di primo grado dell’Unione, è stata avviata una riflessione sulla valorizzazione della composizione multilinguistica delle classi. Si tratta di affrontare il tema della eterogeneità linguistica non come un problema da risolvere, in nome dell’uniformazione linguistica, ma come una risorsa di cui possano beneficiare gli stessi alunni italofoni. Stiamo ragionando sull’attivazione di progetti didattici integrati in cui la diversità linguistica rappresenta un valore in termini formativi. Il progetto è supportato scientificamente dall’Università di Siena e proveremo a diffondere questa idea di didattica multilinguistica”.
Sara Gelli