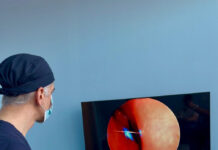Una carneficina. Ecco cos’è. Giorno, dopo giorno, nelle nostre case, si consuma un massacro perpetrato ai danni delle donne. Una mattanza che però non turba la coscienza sociale, collettiva delle comunità. Donne picchiate, sottoposte a violenza psicologica, stuprate, trucidate nelle loro case da mariti, fidanzati o ex partner che le considerano “roba propria”. Cose di cui disporre a proprio piacimento. Ogni donna che subisce violenza rappresenta una sconfitta per l’intera comunità. Ogni schiaffo inferto deve lasciare un segno sulle nostre coscienze perché, come sottolinea la dottoressa Maria Stella D’Andrea, medico legale per le vittime di violenza dell’Ausl di Reggio Emilia e criminologa clinica, “ogni persona può dare quel giusto sguardo a una donna vittima di violenza affinché questa possa sentirsi accolta e compresa. Può essere un Pronto Soccorso, un ambulatorio di medicina generale, un insegnante che coglie attraverso il disagio di un figlio una situazione a connotazione violenta all’interno della famiglia… chiunque intercetti un disagio, chi fa la sentinella sul territorio dovrebbe avere la capacità di coinvolgere la persona in un progetto di affrancamento dalla violenza, attraverso i Centri antiviolenza. Le statistiche ci dicono che, mediamente, passano sette anni dalla richiesta di aiuto di una donna rispetto al primo episodio importante di violenza subito all’interno di relazioni di intimità: in quei sette anni la donna ha incontrato davvero pochi sguardi empatici e accoglienti”.
Ciascuno di noi non solo può essere parte attiva nel riconoscere i germi della violenza ma ha la responsabilità di promuovere una cultura basata sul rispetto e la riabilitazione della figura femminile. Il nostro Paese, infatti, sconta – e come lui molti altri – un ritardo gravissimo in tal senso: “il 5 giugno – prosegue la dottoressa D’Andrea – è uscita la nuova indagine statistica dell’Istat promulgata dal Dipartimento delle Pari Opportunità relativa ai dati della violenza nel 2014 dove si racconta che in Italia 7 milioni di donne sono state vittima di violenza nella loro vita. Noi questi sette milioni non li abbiamo ancora intercettati. Purtroppo ci troviamo di fronte a un vero e proprio deficit di cultura: non sappiamo riconoscere i semi della violenza. Nessun corso di laurea in medicina o in infermieristica prepara il professionista al riconoscimento e allo svelamento delle vittime di violenza. Ciò significa che il fenomeno non viene neppure considerato culturalmente importante. Il nostro problema principale è intercettare le vittime: ci passano davanti nei nostri ambulatori e non le vediamo, transitano davanti ai nostri occhi e non ce ne accorgiamo”.
E la violenza è drammaticamente democratica, radicata nell’asimmetria in termini di potere tra uomo e donna: “il fenomeno – spiega la criminologa clinica – è totalmente e completamente trasversale. Non è legato a etnia, cultura, condizione economica, istruzione e neppure al ruolo sociale. E’ un fatto assolutamente democratico e ubiquitario”.
I maltrattamenti e le violenze nelle relazioni di intimità rappresentano la principale causa di morte o di invalidità permanente tra le donne dai 16 ai 44 anni.
Come può l’uomo che amiamo o abbiamo amato farci del male?
“Il nodo centrale è quello del dominio. Vi sono partner o ex partner che hanno cercato e stanno tuttora tentando di esercitare un dominio nei confronti di una donna e con la parola dominio fa rima il termine possesso e di una cosa che si possiede si può fare ciò che si vuole”.
Esiste un identikit dell’uomo maltrattante?
“Dobbiamo entrare nell’ottica che non vi è alcun identikit. Non esiste uno stigma. Un maniaco. Il diverso da me. Per molto tempo il mondo scientifico si è chiesto se il maltrattante fosse un pazzo o un criminale, in realtà il dibattito è uscito da questo corto circuito per affermare che è un problema culturale dell’uomo legato alla disparità della reciprocità da lui riconosciuta. Non vi sono connotazioni fisiche, caratteriali, geografiche o etniche definite. Tutto sta nel percorso di vita che questo uomo ha compiuto nel suo passato, nel quale la donna aveva un disvalore e dove la relazione con una donna è solo di potere. Ci sentiamo molto protetti dall’immagine del mostro ma in realtà non è di mostro che si può parlare in questo caso”.
Quanto è importante educare i giovani rispetto al tema della parità?
“Lavorare sul concetto di non violenza tra i ragazzi, nelle scuole, è di fondamentale importanza. Iniziare una storia d’amore è semplicissimo, chiudere tale relazione è invece estremamente complesso per le nostre giovani generazioni. Occorre spiegare alle ragazze che ciò che può apparire all’inizio una tenera gelosia in realtà è già un germe che potrebbe creare problemi”.
Può farci alcuni esempi di atteggiamenti che potrebbero costituire un campanello d’allarme per le più giovani?
“Lui che decide cosa devi indossare, con chi devi parlare… lui che vuole a tutti i costi che ogni tot ore lo chiami o lo messaggi… Questi atteggiamenti possono lusingare una ragazza ma in realtà veicolano un altro chiaro e preoccupante messaggio: “tu sei mia”. Una relazione di disparità e violenza psicologica dove il maltrattante diventa dominante inizia sempre allo stesso modo. Ricordiamo però che il controllo non lascia mai spazio alla reciprocità e al rispetto”.
Perché le donne dovrebbero denunciare i propri carnefici?
“Tale percorso dev’essere messo in atto dalla donna nel momento in cui lei stessa riesce ad accettare l’idea di entrare in un circuito di protezione. Molto spesso, infatti, le denunce vengono fatte in momenti di fragilità delle donne le quali poi, tornano sui propri passi innescando legami ancor più patologici. Il senso di denunciare è quello di fermare la violenza e restituire dignità e giustizia a quella donna ed eventualmente ai suoi figli. Ci tengo però a sottolineare che non è una questione di sicurezza pubblica bensì un problema culturale e di riabilitazione della figura femminile”.
Jessica Bianchi