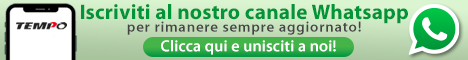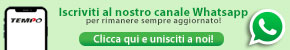Tra le serie tv più viste su Netflix c’è Adolescence, miniserie britannica che sta riscuotendo il giudizio unanimemente entusiasta di pubblico e critica. Un pugno allo stomaco capace di addentrarsi tra le pieghe della società di oggi. Nelle dinamiche adolescenziali, alla scoperta di un linguaggio nuovo, fatto di parole sconosciute ed emoji. Quattro episodi potenti, che raccontano l’incomunicabilità tra padri e figli. Giovani e adulti sempre più fragili. Adolescenti spesso vittime inconsapevoli di ambienti digitali tossici e capaci di veicolare messaggi dalle conseguenze potenzialmente disastrose. Ma cosa rende Adolescence – che racconta la storia di Jamie, un tredicenne accusato di aver ucciso a pugnalate una compagna di scuola – tanto speciale e perchè sta conquistando il cuore di tanti? Lo abbiamo chiesto alla psicologa carpigiana Sandra Frigerio.
Dottoressa, dal pianto alla rabbia. Dalla difesa strenua della sua innocenza alla perdita di controllo. Tutto in un batter di ciglia. Quella del protagonista, il tredicenne Jamie, è una rappresentazione realistica di un adolescente di oggi?
“Dal punto di vista psicologico, la rappresentazione del protagonista Jamie può essere considerata realistica in termini di fluttuazioni emotive e comportamentali tipiche dell’adolescenza. Il passaggio repentino di queste manifestazioni emotive può riflettere le sfide emotive e comportamentali che molti adolescenti affrontano, mentre cercano di navigare le complesse dinamiche della crescita e della costruzione della propria identità. Questa serie televisiva esplora come un adolescente, nonostante provenga da una famiglia apparentemente amorevole e sia considerato un ragazzo intelligente, venga influenzato negativamente dalle pressioni della mascolinità tossica e dai contenuti misogini presenti online. Questi fattori contribuiscono a una visione distorta delle relazioni e dell’autostima, portandolo a comportamenti estremi. Inoltre, la serie mette in luce come subculture online possano radicalizzare i giovani verso atteggiamenti misogini e comportamenti violenti. Viene illustrato uno spaccato delle complesse dinamiche emotive e psicologiche che caratterizzano l’adolescenza odierna, evidenziando l’importanza di un supporto adeguato e di una maggiore consapevolezza riguardo alle influenze esterne che possono modellare il comportamento dei giovani. Tuttavia, è importante notare che la rappresentazione di Jamie potrebbe essere influenzata dalle esigenze narrative della serie e potrebbe non rappresentare l’intera gamma di esperienze adolescenziali. È fondamentale considerare che ogni adolescente è un individuo unico e le sue esperienze possono variare notevolmente”.
Vittima e carnefice allo stesso tempo. Jamie uccide ma è sua volta stato bullizzato dalla ragazza a cui ha tolto la vita. Da lei additato sui social media come Incel, Jamie ripete più volte di essere «troppo brutto» per piacere alle ragazze e cerca di manipolarle per ottenere attenzioni. In che misura i social possono diventare tanto distruttivi?
“I social media possono avere un impatto devastante sulla psiche degli adolescenti, soprattutto in una fase in cui l’identità e l’autostima sono ancora in costruzione. I social media amplificano le insicurezze personali e possono portare a comportamenti autolesionisti o violenti. Tra gli effetti distruttivi dei social media c’è l’amplificazione dell’umiliazione perché nel cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale ci si trova davanti ad un pubblico molto più ampio, aumentando il senso di vergogna e impotenza della vittima. Un altro effetto è la distorsione dell’identità e dell’autostima perché i social troppo spesso promuovono standard irrealistici di bellezza e successo, portando gli adolescenti a confrontarsi con immagini filtrate e idealizzate che alimentano complessi e insicurezze. A questo si aggiunge il sentirsi rifiutati, portando i giovani a trovare rifugio in una visione distorta delle relazioni, cercando di manipolare le ragazze o i ragazzi per ottenere attenzioni. Questo tipo di comportamento può essere alimentato da comunità online tossiche, come la Manosfera o i gruppi Incel, che rafforzano convinzioni misogine e radicalizzano giovani fragili. L’odio e l’aggressività diffusi sui social possono normalizzare atteggiamenti estremi. Il cyberbullismo e l’esposizione costante a contenuti violenti o misogini possono ridurre la capacità di provare empatia, rendendo più facile il passaggio da pensieri aggressivi ad azioni reali”.
Bullismo, solitudine, mascolinità tossica, la radicalizzazione online… vi sono ragazzi/e più inclini a farsi “influenzare” da questi messaggi?
“Certamente alcuni ragazzi e ragazze possono essere più vulnerabili nel farsi influenzare da messaggi negativi. Jamie, per esempio, è un ragazzo già insicuro e socialmente isolato e più facilmente viene trascinato in un vortice di rabbia e frustrazione che lo porta a compiere atti estremi. Gli adolescenti con bassa autostima e insicurezze personali possono essere più propensi a cercare conferme in gruppi che offrono un’identità forte, anche se tossica. L’assenza di amicizie o relazioni significative aumenta il rischio di cercare appartenenza online, dove si può finire in comunità che rafforzano pensieri negativi e ostili. I gruppi estremisti offrono un senso di appartenenza e uno sfogo alla frustrazione, ma alimentano una visione distorta del mondo. Inoltre se in famiglia mancano figure di riferimento che promuovano un modello sano, i giovani possono cercare risposte online, esponendosi a ideologie dannose che promettono una spiegazione semplice ai loro problemi. L’adolescente che ha una bassa tolleranza alla frustrazione o fatica a gestire la rabbia è più incline a reagire in modo estremo a stimoli negativi”.
Il padre di Jamie, nella serie Adolescence, incarna una convinzione comune tra molti genitori: fino a quando un figlio è in casa, apparentemente al sicuro nella propria stanza, non può essere esposto a pericoli. Ma il mondo digitale ha reso la casa un luogo meno protetto di quanto si pensi, soprattutto per gli adolescenti. La domanda centrale è che tipo di controllo può (e dovrebbe) esercitare un genitore sulle frequentazioni online di un figlio?
“Il controllo rigido, fatto di divieti assoluti e monitoraggio invasivo, può spingere i ragazzi a nascondere le proprie attività online o a cercare spazi meno visibili. È più efficace guidarli a un uso consapevole, creando un dialogo aperto sulle loro esperienze digitali. Per un controllo sano e adeguato, un genitore dovrebbe informarsi su social media, piattaforme di gaming e tendenze online per riuscire a individuare rischi e segnali d’allarme. Inoltre nel suo pezzo di responsabilità il genitore e la famiglia dovrebbero creare un ambiente di dialogo in cui il ragazzo o la ragazza sentano di poter parlare senza essere giudicati, per renderli più inclini a condividere le proprie esperienze. Domande come “Che cosa ti piace di più di quel gruppo online?” o “Come ti senti quando leggi quei contenuti?” possono stimolare la riflessione. Un altro aspetto importante è stabilire regole condivise, impostando limiti chiari (ad esempio, non utilizzare i dispositivi in camera di notte o controllo dei tempi di utilizzo) e spiegare il perché di queste regole, aiuta i ragazzi a interiorizzare un uso equilibrato della tecnologia. Un genitore deve imparare a osservare eventuali elementi di disagio che si manifestano con cambiamenti improvvisi di umore, isolamento crescente, aggressività o ossessione per determinati contenuti perché questi possono indicare che qualcosa non va. In tal caso, è fondamentale approfondire senza accusare. Il controllo attraverso l’uso di strumenti di protezione non sostituisce l’educazione digitale e affettiva che invece aiuta i giovani a riconoscere e gestire le emozioni negative legate ai social. I ragazzi trovano spesso modi per aggirare le restrizioni, quindi è più efficace insegnare loro a riconoscere i pericoli. I pericoli della rete (bullismo, radicalizzazione, manipolazione emotiva) non si vedono immediatamente, ma agiscono in profondità. La vera sicurezza non sta nel proibire l’uso di Internet ma nell’insegnare ai ragazzi a difendersi da soli, con pensiero critico e autonomia di giudizio”.
Un altro grande tema che emerge con prepotenza è l’incomunicabilità tra giovani e adulti. Tra padri e figli. Compresi il poliziotto e il figlio. L’adolescenza è da sempre un momento di transizione, di ribellione, di rottura… oggi però rispetto al passato sono cambiati il contesto, gli strumenti, il linguaggio. Perchè oggi sembra tutto più difficile? Sono forse gli adulti a essere più “deboli” e incapaci di farsi carico delle sofferenze dei propri figli?
“La distanza tra genitori e adolescenti è un fenomeno naturale e fisiologico, dovuto al processo di individuazione degli adolescenti. Tuttavia, la velocità con cui i giovani si sviluppano oggi, anche a causa dell’influenza dei social media, rende difficile per i genitori mantenere il passo. Il mondo digitale ha cambiato il modo di relazionarsi: gli adolescenti di oggi vivono una realtà ibrida, tra vita online e offline, con codici comunicativi spesso incomprensibili per gli adulti. Mentre un tempo il conflitto generazionale avveniva faccia a faccia, oggi molte dinamiche di socializzazione si consumano nel mondo virtuale, dove i genitori faticano ad entrare. A questo si aggiunge un cambiamento del linguaggio emotivo, perché gli adulti di oggi sono cresciuti con un’idea diversa di educazione emotiva, dovendo spesso reprimere sentimenti di fragilità e dolore. Gli adolescenti, invece, hanno accesso a un lessico emotivo molto più ampio (attraverso social, serie TV, dibattiti online), ma non sempre trovano negli adulti interlocutori in grado di comprenderli, con l’effetto di frustrazione e dolore. La società è cambiata: la figura del genitore autoritario è stata messa in discussione, ma al suo posto spesso non è stato trovato un modello educativo altrettanto solido. Molti genitori oscillano tra il desiderio di essere amici dei figli e il bisogno di imporre regole, con il rischio di perdere autorevolezza o di risultare incoerenti. Rispetto al passato, oggi si parla molto più di ansia, depressione, disagio psicologico nei giovani. La pandemia ha avuto un impatto significativo sulla salute mentale, con un aumento del 60% nella richiesta di supporto psicologico. Gli adolescenti, in particolare, hanno mostrato un maggiore bisogno di assistenza, evidenziando la necessità di risorse adeguate per affrontare queste sfide. Molti adulti si sentono impreparati ad affrontare il dolore emotivo dei figli e tendono a minimizzarlo, oppure cercano di risolvere i problemi in modo pratico, senza entrare nel vissuto emotivo dei ragazzi. I genitori di oggi si sentono più sotto pressione nel loro ruolo, spesso oberati dal lavoro e dal senso di inadeguatezza. Il padre di Jamie, per esempio, si rende conto di essere stato assente, ma non sa come recuperare il rapporto con il figlio. Questo senso di colpa porta molti adulti ad evitare il confronto diretto, per paura di scoprire di aver sbagliato. A fronte di questa situazione, se un genitore si sente disconnesso dal proprio figlio adolescente, dovrebbe cercare di coinvolgersi nelle sue attività e interessi. Più che deboli, gli adulti di oggi sono più consapevoli delle difficoltà educative, ma meno preparati ad affrontarle. Non si tratta di mancanza di forza, ma di strumenti. La sfida non è tornare a modelli educativi rigidi del passato, ma trovare nuove modalità di comunicazione che tengano conto delle trasformazioni sociali e tecnologiche. L’incomunicabilità raccontata in questa serie televisiva tra genitori e figli è una delle cause del dramma che si consuma. Il vero rischio oggi non è che gli adolescenti si ribellino (perché l’hanno sempre fatto), ma che si sentano soli in questa ribellione, senza adulti in grado di sostenerli”.
Cosa c’è dentro allo straziante «Mi dispiace, avrei dovuto fare di meglio» pronunciato dal padre mentre, con un gesto alquanto simbolico, rimbocca le coperte al peluche del figlio?
“Nella frase pronunciata da questo padre viene espresso il culmine di un dolore profondo, un misto di senso di colpa, impotenza e tardiva consapevolezza. Il gesto simbolico di rimboccare le coperte al peluche del figlio rappresenta il bisogno di prendersi cura di Jamie, anche se ormai è troppo tardi. Emerge il rimorso di un padre assente che ha trascorso anni pensando che la sua sola presenza fisica in casa fosse sufficiente a proteggere il figlio. Solo dopo la tragedia realizza quanto fosse distante emotivamente e quanto poco abbia compreso il dolore e la rabbia che il figlio portava dentro. È la consapevolezza di non aver visto i segnali, di non aver colmato quel vuoto che il giovane ha cercato di riempire altrove, finendo in dinamiche pericolose. Rimboccare le coperte a un peluche è un gesto che di solito si fa con i bambini piccoli, un atto di protezione e premura. Farlo ora, con un figlio che non c’è più, rappresenta un modo per esprimere un amore che non è riuscito a dimostrare prima. È un gesto inutile dal punto di vista concreto, ma simbolico, come un ultimo tentativo di essere il padre che avrebbe dovuto essere. C’è un’emergenza educativa in cui il digitale diventa l’amplificatore. Il problema non è la fragilità dei giovani ma il fatto di non volerla vedere. La famiglia dovrebbe rappresentare il contenitore che protegge i suoi membri, fungendo da argine contro le difficoltà esterne. La famiglia ha subito trasformazioni significative nel corso della storia, passando da un modello rurale a uno urbano. Questi cambiamenti hanno influenzato le dinamiche interne e il ruolo dei membri della famiglia. Con l’avvento del digitale e ancor di più con l’esperienza della pandemia è cresciuta l’illusione di pensare i figli al sicuro in casa, ma in realtà è la loro psiche a non essere protetta”.
In Adolescence non esistono “buoni” e “cattivi”. Non c’è un lieto fine e non vi è spazio per la redenzione e questa forse è proprio la sua forza: quella di raccontare la complessità senza fare sconti. Una complessità, reale e virtuale, che non può essere affrontata con gli strumenti di ieri, (ti metto in punizione e non esci con gli amici per una settimana) e le categorie mentali del passato (se lo avessero punito quando era piccolo…). E allora come si può attrezzare un genitore per rendere più “forte” il proprio figlio?
“È un racconto spietato della complessità del mondo adolescenziale, dove la sofferenza si intreccia con l’incapacità degli adulti di comprenderla. I genitori hanno un ruolo fondamentale nell’educazione e nella responsabilizzazione dei figli, influenzando il loro sviluppo emotivo e sociale. Dare loro strumenti emotivi e non solo regole è un importante passaggio: le punizioni rigide come unico tentativo oggi rischiano di essere inefficaci o addirittura controproducenti. I ragazzi non hanno bisogno solo di limiti, ma di strumenti per capire e gestire le proprie emozioni. L’educazione emotiva è fondamentale per aiutare i giovani a riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni. Le emozioni di base sono universali e devono essere affrontate in modo aperto e onesto. Educare all’affettività significa insegnare ai giovani a riconoscere e gestire le proprie emozioni per riuscire a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e a prevenire comportamenti negativi. Un genitore non può monitorare ogni aspetto della vita del figlio, soprattutto in un mondo iperconnesso, ma può essere un punto di riferimento e modello di comportamento positivo, attraverso un dialogo aperto, senza il peso del giudizio. Il genitore per proteggere il figlio e la sua psiche dovrebbe chiedere al proprio figlio se si sente “visto” o chiedergli di aiutarlo a vederlo. Nel tentativo di proteggere i figli, molti genitori tendono a risolvere i problemi al posto loro, impedendo loro di sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e di sviluppare la resilienza. È importante insegnare ai giovani, sempre più immersi in una società performante, che il fallimento fa parte della crescita e che non è una vergogna, mostrando loro che chiedere aiuto non è debolezza, ma una risorsa. Non avere paura di mostrare fragilità: un genitore che ammette di non avere tutte le risposte, ma che è disposto ad ascoltare e capire, è più credibile e vicino ai figli. Laddove il figlio mostrasse segnali di sofferenza, è essenziale coinvolgere e affidarsi a uno specialista, un insegnante, o una figura di supporto. Conoscere il mondo digitale è un altro strumento: la complessità del mondo virtuale non può essere affrontata con le categorie del passato. È inutile dire “staccati da quel telefono” senza comprendere il valore che il digitale ha per i ragazzi. I social, i gruppi online, i forum possono essere spazi tossici, ma anche luoghi di confronto e crescita. Un genitore può rendere un figlio più forte aiutandolo a sviluppare un pensiero critico su ciò che vede online, senza demonizzare o vietare tutto. Parallelamente incoraggiare relazioni sane e sostenere amicizie e attività che aiutino a costruire un’identità positiva e sicura. La vera sfida è dare loro strumenti per affrontare la realtà, sviluppare una sorta di bussola interiore che li aiuti a orientarsi anche nei momenti difficili. In un mondo in cui non ci sono più risposte semplici, la vera forza è sapersi adattare, capire le proprie emozioni e chiedere aiuto quando serve. Il risultato di questo approccio sarà lo sviluppo di una consapevolezza affettiva, intesa come la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri, e la promozione dell’indipendenza e responsabilità nei giovani. La prevenzione è possibile solo creando un ambiente che offra ai giovani strumenti migliori per affrontare le proprie fragilità”.
Jessica Bianchi