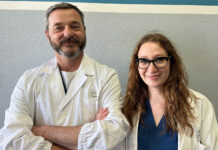Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, e ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono. Torna spesso, questa frase de La tregua di Primo Levi, nelle parole di Liliana Segre. Ospite d’onore, giovedì scorso in un affollato Auditorium San Rocco, del Convegno internazionale sui campi di transito europei promosso dalla Fondazione Ex-Campo Fossoli, la senatrice a vita, nonché deportata a soli 13 anni nel campo di sterminio di Auschwitz, dove perse il padre e i nonni paterni – vittime, insieme ad altri milioni di esseri umani ebrei, zingari, omosessuali, disabili o oppositori politici, delle fabbriche di morte naziste – ha ripetuto più volte la potenza delle parole di Levi. Frasi che, nel descrivere lo sguardo dei giovani soldati sovietici che per primi aprirono le porte di Auschwitz dopo la fuga dei nazisti, ritrovandosi davanti pile di cadaveri e pochi superstiti ridotti a relitti umani, testimoniano in modo preciso una sensazione che negli anni la Segre ha sempre provato. “Lo stupore, per il male altrui, non era mai abbastanza. Io ragazzina, gettata in mezzo a quel male assoluto per la sola colpa d’esser nata, diventata un orrore, uno scheletro, una lupa affamata, mi chiedevo perché. Perché delle persone avessero preparato, per altri esseri umani, un posto così. Perché, a compiere un tale male, non fossero mostri o pazzi, ma uomini e donne uguali a me”. Liliana Segre ha ripercorso la propria vita, dall’infanzia felice, con un padre amatissimo, al tentativo di fuga in Svizzera, arrivando alla frontiera (“eravamo dei richiedenti asilo e fummo respinti con disgusto, disprezzo, senza pietà”), sino al giorno della deportazione in Polonia, caricati sui carri bestiame dai sotterranei della Stazione centrale della sua città. “Ci fecero sfilare in seicento, come fantasmi, per una Milano deserta e indifferente. Ci caricarono come animali da portare al macello, con calci, pugni, insulti. E non c’erano solo nazisti, ma anche i nostri vicini di casa, fascisti, che ci martoriavano per fare buona impressione sui loro alleati”. E poi il viaggio, con un padre senza più lacrime, né la forza di parlare. La divisione tra uomini e donne appena scesi dal treno, le selezioni tra gli abili e gli inabili al lavoro e un unico, assillante pensiero: “mangiare. Davanti alla morte quotidiana non pensavamo che a quello. Inventavamo tra noi i piatti più ricchi, più dolci, più grandi, promettendoci reciprocamente che, se mai fossimo sopravvissute, ci saremmo reciprocamente invitate a casa le une delle altre per cucinarli tutti”. E, ancora, la marcia della morte, centinaia di chilometri al gelo, senza vestiti, senza cibo, in condizioni disumane, perché ci si doveva allontanare dall’esercito Russo che avanzava: “e non ci si poteva fermare, arrendersi, un passo dopo l’altro, perché chi si accasciava, stremato, veniva finito dalle guardie con un colpo di pistola alla testa, perché i nazisti non volevano lasciare alcun testimone in vita per raccontare ciò che ci avevano fatto. Ai ragazzi ripeto sempre di non dire mai che non ce la fanno più, perché io so come siamo forti, io l’ho visto”. Liliana Segre, di tedesco, aveva un vocabolario di dieci parole, quelle utili nel contesto concentrazionario: paura, fame, neve, morte, vita, il proprio numero di riconoscimento, stampato sul braccio, per poter rispondere all’appello. Liliana Segre, quando arriva il giorno in cui i suoi torturatori si mettono in borghese, gettano le armi e scappano, lasciandola finalmente libera, si chiede: “Ma liberi da cosa? Da quel che abbiamo dentro? Da tutti coloro che abbiamo perso?”. Un racconto che passa dal ritorno a casa, quello fisico e, soprattutto, quello interiore, molto più lungo. “Sarei diventata una donna disadattata, di quelle che, quando si incontrano per la strada, si guardano con pietà, se non avessi avuto due grandi fortune: rimettermi a studiare e incontrare l’uomo che divenne mio marito, e il cui amore straordinario fu la mia salvezza, perché mi fece capire come, nonostante tutto quello che avevo passato, ero ancora capace di innamorarmi”. Nonna affettuosa di tre nipoti amatissimi, Liliana ripete costantemente un messaggio: “Si è così ricchi, se si ha pietà”.
Marcello Marchesini